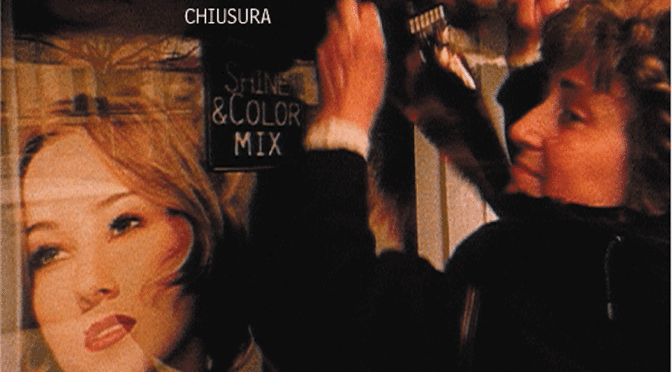Rivedere a ventuno anni dalla sua uscita Chiusura di Alessandro Rossetto rende ancora più ardua l’analisi del film. Vedere un mondo che non c’è più, percepire la consapevolezza che esso stesso aveva di essere giunto a una fase terminale, la fine di un millennio e tutte le paure a esso annesse, genera nello spettatore un misto di ansia e tenerezza. C’è l’amore per un passato che sta svanendo ma, allo stesso tempo, la consapevolezza che non molto è cambiato. La provincia rimane a distanza di anni un luogo paludoso, stagnante, a cui è difficile fuggire ma che attraverso l’immagine cinematografica ha un richiamo romantico e affascinante. È proprio la capacità di mostrare questa doppia anima della provincia e questo scarto tra tradizione che svanisce e modernità che avanza a rendere grande il cinema di Alessandro Rossetto. Chiusura, come detto dallo stesso regista, è un film che a distanza di anni è diventato una riflessione sul tempo che passa.
Leggi tutto: “CHIUSURA” DI ALESSANDRO ROSSETTOIl documentario, restaurato sotto la supervisione di Rossetto stesso dall’Istituto Luce, segue la chiusura del negozio di parrucchiera della signora Flavia dopo 44 anni di attività. Il regista, laureato in antropologia, osserva attentamente i piccoli gesti di questo mondo, le parole degli abitanti che lo abitano, i conflitti che lo animano. A questo mondo se ne affiancano altri: il circo che arriva in città e la squadra di calcio femminile locale. L’osservazione di questi mondi si concentra allo stesso modo sugli impercettibili riti e conflitti, sulle emozioni personali delle persone che li abitano.

Ad aleggiare su questo microcosmo è però la nebbia invernale, elemento costante del film, che amplifica la sensazione di staticità e pure di fine, di chiusura di un periodo giunto ormai al suo termine. A spiccare però è la bellezza di questi elementi e la capacità del cinema del reale di dare fascino alle cose della vita comune. La sensazione di paralisi trascende e diventa bellezza: i gesti, le parole e i discorsi personali divengono ammalianti e affascinanti agli occhi dello spettatore.
Il tempo trascorso amplifica quindi l’esperienza di visione di Chiusura, a cui la riflessione sul tempo e la fine di un’era si aggiunge la riflessione a posteriori su un periodo che ormai è trascorso, ma le cui emozioni e sensazioni rimangono ancora incredibilmente vivide.
Cristian Cerutti